A Lhasa, nel marzo 1959, la Cina ha soffocato le proteste, massacrando migliaia di civili e, in violazione degli accordi sottoscritti nel 1951, ha sciolto il governo tibetano trasformando il Tibet in una provincia cinese. È stato l’inizio della politica con cui il PCC ha deciso di ignorare il diritto internazionale e di rispondere alle proteste nel mondo diffondendo fake news

Massimo Introvigne
Il 2019 segnerà il sessantesimo anniversario della Battaglia di Lhasa del 1959, una svolta cruciale nella storia delle violazioni dei diritti umani da parte del Partito Comunista Cinese (PCC) in aperta sfida alle norme e alle convenzioni internazionali. Ciò che sta accadendo ora nello Xinjiang è infatti la logica continuazione di una politica iniziata in Tibet negli anni 1950. Per il PCC, il perseguimento dei propri interessi ideologici è più importante dell’immagine che esso ha a livello internazionale e delle sue relazioni pubbliche. Di fronte alle critiche che oramai piovono da tutto il mondo, la prima reazione del PCC è dunque quella di inventare fake news.
La maggior parte di ciò che in precedenza non era noto sulla Battaglia di Lhasa, almeno ai lettori occidentali che non hanno familiarità con le lingue cinese e tibetana, può essere ora reperito nell’edizione in lingua inglese del saggio Tibet in Agony: Lhasa 1959 di Li Jianglin, una storica cinese che si è formata a livello accademico negli Stati Uniti, dove vive. Il libro della Li, pubblicato dalla Harvard University Press nel 2016, è un’edizione aggiornata e ampliata del testo già pubblicato nel 2010 in cinese a Taiwan e a Hong Kong. È lo studio definitivo sull’argomento.
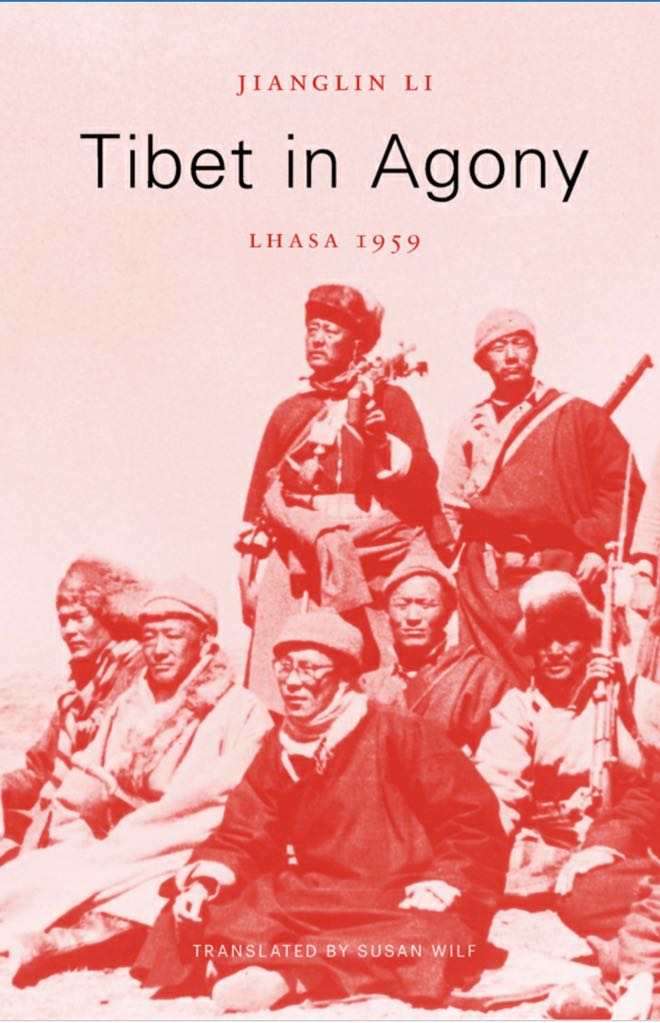
Il punto chiave del pensiero della Li è che la maggior parte degli equivoci relativi al Tibet si basino su una conoscenza incompleta della geografia. Cos’è esattamente il Tibet? Se per Tibet si intende l’area in cui la maggioranza della popolazione parla la lingua tibetana e crede nella religione buddhista tibetana, allora il territorio di ciò che oggi la Cina definisce Regione autonoma del Tibet (TAR) ne comprende solamente la metà. L’altra metà comprende le regioni tradizionalmente chiamate Amdo e Kham, oggi divise tra le province cinesi del Qinghai, del Gansu, del Sichuan e dello Yunnan. Quest’area più ampia viene chiamata dai geografi e dagli storici «Tibet etnico», mentre l’attuale TAR è il «Tibet politico». Ciò detto, dal punto di vista storico e giuridico il fatto che il Tibet fosse giuridicamente indipendente prima dell’invasione cinese del 1950 costituisce un problema complesso.
Nessuno dubita, però, che godesse di una indipendenza di fatto e che, ai fini pratici, fosse amministrato dal Dalai Lama e dal suo governo. Questa constatazione pertiene al territorio dell’attuale TAR (più l’area chiamata Chamdo, che i cinesi occuparono nel 1950 separandola dal Tibet politico). Prima che il PCC salisse al potere nel 1949, sia la Cina sia il Tibet rivendicavano la sovranità sull’Amdo e sul Kham, ma nessuna delle due potenze le controllava. La miriade di piccole realtà in cui queste due regioni erano suddivise era governata dagli abati dei monasteri buddhisti o da capi tribù ereditari.
Dai documenti citati da Li emerge con assoluta chiarezza come il presidente Mao (1893-1976) abbia deciso, sin dalla propria ascesa al potere, di impadronirsi di tutto il Tibet onde farne una provincia cinese. Tuttavia, al fine di evitare o di limitare le reazioni internazionali, Mao ha ritenuto che l’obiettivo dovesse essere raggiunto con gradualità e con pazienza.
In primo luogo, Mao si assicurò il controllo dell’Amdo e del Kham, aree culturalmente e religiosamente tibetane, ma non controllate dal governo tibetano di Lhasa. Già la Cina repubblicana aveva suddiviso questi territori in varie province cinesi, ma si trattava di una divisione puramente teorica, poiché, in realtà, questi territori continuavano a essere amministrati da governanti tradizionali autonomi. Mao si era invece rapidamente sbarazzato dei governanti tradizionali, convertendo la teoria repubblicana in pratica comunista.
Secondo, il Tibet politico, oltre alla capitale Lhasa, consisteva di sei suddivisioni principali. La parte più orientale, al confine con il Kham, si chiamava Chamdo. Dopo essere salito al potere nel 1949, Mao aveva rilanciato le antiche pretese cinesi secondo le quali il Chamdo non fa parte del Tibet. Aveva quindi creato il Comitato comunista di liberazione del Chamdo, che si ribellò all’autorità di Lhasa. Nell’ottobre 1950 le truppe cinesi invasero la regione proclamandone l’autonomia sotto il governo del Comitato di liberazione del Chamdo (poi assorbito nel TAR).
Nel 1950 Mao riteneva prematuro far marciare l’esercito cinese verso Lhasa. Non che avesse molto da temere dall’esercito tibetano, piccolo e scarsamente armato. Temeva però le reazioni internazionali. L’occupazione del Chamdo aveva comunque mandato un messaggio chiaro ai tibetani, che, nel 1951, avevano dovuto firmare, costretti, l’Accordo in Diciassette Punti di Pechino, di cui tre fondamentali. Anzitutto si riconosceva che il Tibet facesse parte della Cina. Secondo, si prometteva che il Tibet avrebbe continuato a essere amministrato internamente da un governo proprio e dalle tradizionali strutture religiose e sociali, mentre la Cina avrebbe gestito gli affari esteri. In terzo luogo, si permetteva che un massiccio contingente di soldati cinesi stazionasse a Lhasa, dando infine libero sfogo alla propaganda del PCC in Tibet.
Nel 1950 l’attuale Dalai Lama aveva quindici anni. Era un giovane precoce e imparava rapidamente, ma era ancora uno studente (fino al 1959 uno dei suoi compiti principali è consistito nel prepararsi per dare gli ultimi esami universitari) e doveva fare affidamento sui tutori, sui consiglieri e sui ministri, alcuni dei quali, come ora si sa, erano agenti del PCC che facevano il doppio gioco. Come il saggio della Li precisa, il Dalai Lama ha creduto fino alla fine (e, in un certo senso, anche dopo) di poter trattare con il PCC. La studiosa afferma che, all’epoca, quasi nessuno in Tibet aveva compreso pienamente la strategia di Mao e che persino dopo l’hanno capita solo pochi specialisti. Fra l’altro i documenti chiave della vicenda sono stati declassificati o sono trapelati solo recentemente.
Mao aveva avviato la “sinizzazione” del Tibet etnico iniziando dal Kham e dall’Amdo a metà degli anni 1950. Ciò significava che la secolare struttura sociale era stata distrutta, che diversi capi tradizionali erano stati arrestati o giustiziati e che i monasteri buddhisti erano stati chiusi, alcuni addirittura distrutti. Gli storici occidentali hanno a lungo creduto che Mao abbia commesso un errore consistente nel non avere previsto che la sinizzazione brutale e prematura del Kham e dell’Amdo avrebbe provocato una rivolta. A migliaia si sono infatti uniti alla guerriglia dei Difensori della fede Chushi Gangdruk, i quali, nonostante l’equipaggiamento inadeguato, alla fine riuscirono a infliggere gravi perdite ai cinesi. La sinizzazione avrebbe inoltre infiammato i sentimenti anticomunisti nel Tibet politico, dove i profughi di quelle regioni avevano iniziato a fuggire.
In realtà, i documenti portati alla luce dalla Li dimostrano che è vero il contrario. Mao aveva creato scientemente le condizioni per una rivolta nel Kham e nell’Amdo, e desiderava con tutto il cuore che nel Tibet politico scoppiasse presto una rivolta anticinese. E tanto più violenta fosse stata, tanto meglio sarebbe stato. Questo avrebbe infatti dato al PCC il pretesto per occupare il Tibet e rimuovere il governo del Dalai Lama, sostenendo in sede internazionale di stare semplicemente difendendo le truppe e i cittadini cinesi di Lhasa dai «banditi reazionari». La sua corrispondenza segreta mostra quanto spesso Mao avesse rimproverato i dirigenti locali del PCC che avevano cercato di prevenire l’insurrezione, laddove invece le istruzioni di Pechino erano proprio di provocarla.
Mao non era però onnisciente, nonostante gli storici comunisti cinesi abbiano successivamente sostenuto il contrario. Mentre dapprima aveva considerato irrilevante il fatto che il Dalai Lama potesse fuggire all’estero, finì per ordinare d’impedirlo. Il Dalai Lama era infatti riuscito a fuggire in India, grazie al coraggio delle proprie guardie del corpo e alla loro superiore conoscenza dei sentieri sulle montagne himalayane, e non perché Mao, nella sua magnanimità, gli avesse permesso di farlo. Il presidente cinese si è interrogato a lungo su come l’Occidente avrebbe reagito all’invasione del Tibet, anche se nel 1957 due elementi lo confortavano. Primo, nel 1956 l’Occidente non aveva reagito all’invasione sovietica della ben più vicina Ungheria. Secondo, il primo ministro indiano Jawaharlal Nehru (1889-1964), come ora si apprende da documenti indiani recentemente declassificati, lo aveva assicurato non solo che l’India non avrebbe interferito, ma che pure gli era stato detto dal presidente degli Stati Uniti Dwight D. Eisenhower (1890-1969) che nemmeno l’America sarebbe andata in guerra per il Tibet.
Così, alla fine degli anni 1950, Mao non solo aveva ordinato all’esercito di reprimere la resistenza buddhista del Kham e dell’Amdo nel modo più brutale possibile, bombardando i monasteri e distruggendo statue venerate del Buddha, ma aveva anche detto ai rappresentanti del PCC e ai suoi agenti nel Tibet politico di moltiplicare le provocazioni, sperando che a Lhasa potesse esplodere presto una rivolta. Il 24 giugno 1958 Mao dichiarava dunque, in un documento segreto, che il PCC avrebbe dovuto favorire «una ribellione su vasta scala in Tibet. Quanto più grande, tanto meglio».
Una delle provocazioni consistette nel diffondere la voce che il PCC avesse intenzione di rapire il Dalai Lama per portarlo a Pechino. La strategia ebbe successo e, quando il 10 marzo 1959 il giovane Dalai Lama accettò l’invito a partecipare a uno spettacolo di danze cinesi al comando militare dell’esercito cinese di Lhasa, la voce che il PCC stesse per attuare il sequestro si diffuse a macchia d’olio nella capitale tibetana. Una grande folla si radunò quindi attorno alla Norbulingka, la residenza del Dalai Lama, per impedirgli di uscire. Vennero urlati slogan contro Mao, ma contro l’esercito cinese non fu esploso nemmeno un colpo. L’unica vittima della prima giornata fu un uomo politico tibetano favorevole al PCC, che la folla aveva riconosciuto e ucciso.
All’insaputa dei tibetani e del mondo, tranne forse dell’Unione Sovietica e dell’India, che, diffidando dei propri “amici” cinesi, continuavano a spiarli, Mao disponeva di un piano dettagliato per l’invasione. A ridosso del confine con il Tibet politico aveva schierato un esercito potente di cui facevano parte corpi d’élite che avevano combattuto nella Guerra civile e nella Guerra di Corea. Ciò prova che Mao sapesse già prima del 10 marzo che l’invasione avrebbe avuto luogo in ogni caso. Tra il 10 e il 20 marzo la tensione a Lhasa era aumentata. I cinesi avevano schierato apertamente l’artiglieria, pronta a colpire i palazzi storici e i monasteri tibetani. I Difensori della fede Chushi Gangdruk arrivarono a Lhasa dalle montagne, e anche questo era ciò che Mao voleva. Era quella che chiamava la «vecchia tattica cinese», consistente nel far venire i topi allo scoperto per poi ucciderli tutti. Iniziarono ad armarsi anche monaci e civili con fucili e cannoni ottocenteschi, le uniche armi disponibili in città.
Mentre il Dalai Lama credeva ancora di poter negoziare, e scriveva lettere umili ai comandanti dell’esercito cinese, Mao aveva già ordinato di attendere pazientemente che i tibetani «sparassero i primi colpi» per poter iniziare la guerra dicendo al mondo che fosse «difensiva». Non tutto però ha funzionato esattamente come Mao aveva previsto. Il comandante dell’esercito cinese a Lhasa, infatti, il generale Tan Guansan (1908-1985), sentendosi minacciato, non attese un verosimile primo colpo tibetano, né le truppe di rinforzo che stavano arrivando dalla Cina, e diede inizio a quella che sarebbe state poi chiamata la Battaglia di Lhasa del 20 marzo. Con l’artiglieria Tan distrusse diversi templi tibetani ed edifici storici, compresa la Norbulingka, facendo uccidere senza pietà soldati, miliziani e civili tibetani che tentavano di difenderli. In un raro gesto di perdono, Mao non punì il generale per aver agito prima di ricevere gli ordini di Pechino, giacché ammirava la ferocia con cui era stata stroncata la resistenza tibetana. I vecchi peccati sono però tornati a perseguitare il generale Tan e i suoi principali collaboratori in Tibet durante la Rivoluzione Culturale. Tan è stato perseguitato, anche se è sopravvissuto e poi è stato riabilitato, ma altri esponenti del PCC in Tibet che durante la Battaglia di Lhasa avevano svolto ruoli chiave sono morti in prigione.
La Battaglia di Lhasa è durata solo quattro giorni: all’esercito cinese non è servito molto per domare contadini e monaci armati in modo primitivo. Tutto ciò che i tibetani hanno potuto ottenere è stato quindi mettere in salvo il Dalai Lama nell’esilio indiano, dove ancora si trova. Il numero delle vittime tibetane è ancora un segreto militare che la Cina custodisce gelosamente, ma probabilmente si tratta di migliaia di persone (mentre la propaganda cinese insiste nel dire che sarebbero state solo centinaia). Molti altri tibetani sono stati arrestati e deportati, e di questi molti sono morti in prigione.
La Battaglia di Lhasa ha posto fine al Tibet tradizionale e autonomo, ha sciolto il governo del Dalai Lama, ha ridotto la libertà religiosa e ha trasformato il Tibet politico in una provincia della Cina, ribattezzata pomposamente, ma in modo fuorviante, «regione autonoma». La battaglia ha impartito anche due lezioni importanti a chi studia la storia del PCC o analizza l’attuale persecuzione di altre minoranze etniche e religiose. Primo, il PCC è disposto a perseguire le proprie politiche anche a prezzo di un considerevole ludibrio a livello internazionale. Ciò che era accaduto in Ungheria nel 1956 aveva confermato al PCC che l’Occidente non era pronto a mandare i propri soldati a “morire per Budapest”, e tanto meno per Lhasa o per lo Xinjiang (che alcuni siano invece morti per Saigon è una questione diversa e più complessa). In secondo luogo, il PCC non si limita a ignorare le proteste che giungono da tutto il mondo, perché con l’esperienza ha imparato che organizzare campagne di fake news è più economico e semplice che fare la guerra.
Nel 1959 non esistevano né Internet né i social media. Il PCC ha però ottenuto un notevole successo relativo nel dare al mondo la propria versione dei fatti. Alcune delle fake news che sono state diffuse sostenevano che i tibetani avessero avviato la rivolta senza essere stati provocati e che le masse erano manipolate dal governo reazionario del Dalai Lama. Invece è vero il contrario, perché Mao ha fatto tutto il possibile per istigare la rivolta, e il Dalai Lama e il suo governo hanno tentato ogni passo per impedirla e negoziare. Nemmeno la propaganda del PCC è riuscita però a vendere una parte della storia: infatti nessuno, al di fuori della Cina, ha mai davvero creduto che il Dalai Lama fosse stato “rapito” da “reazionari”, né che Mao magnanimamente ne avesse facilitato la fuga. Tuttavia su Wikipedia e altrove è ancora possibile trovare altre leggende, compresa quella secondo cui la CIA avrebbe organizzato la rivolta. Quanto alla CIA, si era interessata sì al Tibet, addestrando, nel 1957, a Okinawa e a Saipan sei membri dei Difensori della fede Chushi Gangdruk, per poi paracadutarne cinque in Tibet con una radio (il sesto si era sparato accidentalmente su un piede ed era rimasto a Okinawa). La radio era cruciale giacché la missione di quegli uomini consisteva essenzialmente nell’infrangere la cortina informativa che i cinesi avevano eretto e trasmettere alla CIA rapporti di prima mano su ciò che stava accadendo, non organizzare o condurre una rivolta.
Il libro della Li è insomma uno strumento eccellente per sfatare un buon numero di fake news. Quante sono però le persone che leggono i libri accademici pubblicati dalla Harvard University Press invece che affidarsi alla molto più facilmente accessibile propaganda cinese?
















