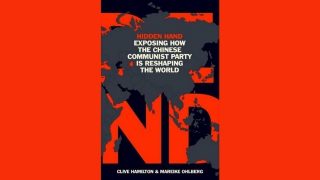La Cina di Xi Jinping si crede una civiltà superiore che guiderà il mondo. 10 milioni di “coloni” in missione per conto del PCC “civilizzeranno” gli “arretrati”

Marco Respinti
Il quotidiano internazionale del PCC, Global Times, lo ha sottolineato con enfasi e orgoglio: «La Cina sta progettando di mobilitare oltre 10 milioni di giovani volontari per contribuire a promuovere lo sviluppo culturale, tecnologico e medico delle aree rurali entro il 2020, una mossa che i funzionari locali dicono contribuirà a rilanciare le aree rurali colpite dall’esodo dei giovani lavoratori di talento». Lo afferma un documento recente, pubblicato dalla Lega della gioventù comunista cinese (LGCC).
Laddove sarebbe interessante analizzare il concetto di “volontario” in un Paese totalitario che controlla la propria popolazione con ogni possibile mezzo tecnologico e dove le persone sono libere di fare solo quello che il regime dice e vuole, il punto serio qui in gioco è il dispiegamento di un vero e proprio esercito coloniale ideologico volto a “innovare” diversi territori e persone che il PCC giudica arretrati.
Gli effettivi di questa task force serviranno «[…] come funzionari locali part-time» per formare i giovani esperti che il regime sta inviando nelle aree rurali con l’obiettivo di invertire la tendenza migratoria da «regioni meno sviluppate ad aree sviluppate, alla ricerca di condizioni di vita e di guadagni migliori». Gli emissari della LGCC insegneranno a questi talentuosi giovani come «amministrare le campagne», usando, come dice Zhang Linbin, vice-responsabile di una municipalità della provincia dell’Hunan, nella Cina centrale, «[…] la scienza e la tecnologia per aiutare le campagne a innovare i propri modelli tradizionali di sviluppo». Questa politica, precisa il Global Times, «[…] mira a costruire una serie di basi formative nelle aree rurali di modo che i giovani possano avviare le proprie attività oppure trovare lavoro e a formare più di 200mila giovani entro il 2020».
Nel linguaggio asettico usato dal giornale del PCC significa che Pechino sta lanciando una massiccia campagna per rieducare vaste aree del Paese allo scopo di “aggiornare” le persone e portarle al livello previsto e dunque richiesto dagli standard del socialismo per una “Nuova Era”, la formula politica che Xi Jinping ha lanciato e implementato dal momento stesso in cui ha assunto la guida del PCC nel 2012 e quella del Paese nel 2013.
Ma questa tendenza ricorda, in molti modi, la guerra dichiarata dal presidente Mao ai «Quattro vecchiumi», quando, durante la Rivoluzione Culturale, il Partito puntava a comunistizzare la società cinese distruggendo tutti gli elementi della cultura pre-comunista che giudicava incompatibili con l’ideologia rossa giacché vestigia inutili e persino pericolose del passato: vecchie usanze, vecchia cultura, vecchie abitudini e vecchie idee.
Lo stesso parallelismo viene notato da The Guardian, che parla di «[…] timori di un ritorno» ai «metodi» «brutali» «di 50 anni fa». Le aree rurali povere che la LGCC punterà a “modernizzare” sono, infatti, di frequente abitate da minoranze etniche e, come dice il quotidiano britannico, «le relazioni tra la maggioranza han, che costituisce oltre il 90% della popolazione, e le minoranze etniche, quali i tibetani e gli uiguri musulmani, sono spesso tese». Ciò che i tibetani, gli uiguri e altre minoranze musulmane che vivono in Cina quali i kazaki soffrono viene raccontato quasi quotidianamente da Bitter Winter. Forse che il PCC stia sferrando un nuovo attacco potenzialmente fatale a queste minoranze “arretrate” per spingere la “sinizzazione” al culmine e virtualmente alla fine?
«Civiltà»: la fase uno
C’è una parola che sta diventando un mantra nei discorsi pubblici delle autorità comuniste: wenming (文明), ovvero «civiltà». Alison Kaufman, ricercatrice del Center for Naval Analyses di Arlington, in Virginia, negli Stati Uniti d’America, settore “Studi sulla Cina”, ne illustra il concetto e l’uso nella Cina odierna, così come le sue importanti implicazioni a livello mondiale, in un recente saggio scientifico pubblicato da The Asan Institute for Policy Studies, un think tank indipendente di Seoul, in Corea del Sud.
«Nei discorsi pubblici e negli scritti», scrive la Kaufman, «Xi Jinping (come i suoi predecessori) ha usato il termine “civiltà” in almeno tre modi diversi. Nessuno di questi modi è, di per sé, appannaggio esclusivo di Xi o applicabile solo alla Cina». Il primo, spiega la specialista, rende più o meno l’idea di “società” o di “popolo”. Il secondo è un concetto molto simile al termine “cultura”. Il terzo «[…] non fa riferimento a un gruppo storico specifico di persone, bensì a un processo di sviluppo umano» che «nel secolo XIX» le élite cinesi hanno cominciato a considerare «[…] sotto una nuova luce, attingendo a testi occidentali che intendevano la nozione di “civiltà” come un processo dinamico attraverso il quale alcune società umane hanno progredito lungo la storia laddove altre sono rimaste indietro». Ovvero «[…] un modo di essere progressivo, dinamico e aspirazionale, e questo è in contrasto con le società “non civilizzate” che sono caratterizzate da stagnazione e da passività». In questa concezione, una «società civilizzata è superiore a quella non civilizzata» ed «è gerarchica, giacché molte versioni di questa linea di pensiero sostengono che la società civilizzata dominerà naturalmente quelle non civilizzate».
Quindi, «l’essere “civilizzati” era considerata la soglia per godere della cittadinanza piena e del riconoscimento pieno nel panorama globale. Tutto il progetto di modernizzazione della Cina, dal 1840 a oggi, può essere visto come lo sforzo per diventare “civilizzati” in questo terzo senso del termine, cioè per riorientare le proprie caratteristiche interne in modo tale da garantirsi forza di Paese unitario, autodeterminazione e influenza sul piano mondiale».
Rielaborando questi materiali, nel 1900 lo studioso e riformatore cinese Liang Qichao (1873-1929) ha pubblicato un saggio, 少年中國說, «Giovane Cina», per denunciare l’incapacità della comunque grande cultura tradizionale cinese a far diventare il Paese uno Stato moderno civilizzato, giacché, a suo avviso, «[…] i valori tradizionali cinesi erano talmente antitetici al processo civilizzatore che, se la Cina avesse voluto sul serio progredire, avrebbe dovuto abbandonarli del tutto».
I primi dirigenti del PCC, osserva la Kaufman, «[…] hanno adottato un’analoga visione del passato cinese. Per il Partito, le antiche tradizioni “feudali” e “imperialiste” ostacolavano la creazione di quella “civiltà socialista” e di quella “cultura rivoluzionaria” che avrebbero finito per diffondersi in tutto il mondo. Quando annunciò l’intenzione di “distruggere i quattro vecchiumi” all’inizio della Rivoluzione Culturale, il PCC pretese che i cinesi eliminassero “le vecchie cose, le vecchie idee, i vecchi costumi e le vecchie abitudini” poiché questi “quattro vecchiumi” avevano “avvelenato le menti del popolo lungo migliaia di anni” per mano delle “classi sfruttatrici”. L’unico modo per rimpiazzarli con “costumi e abitudini proletarie completamente nuovi” era eliminare le abitudini materiali, filosofiche e sociali su cui poggiava la civiltà cinese “tradizionale”». Qichao e Mao, conclude la studiosa, hanno «[…] nutrito prospettive molto diverse sul futuro che speravano di portare alla Cina», ma «hanno raggiunto conclusioni simili su come arrivarci: la Cina potrà diventare “civilizzata” solo abbandonando il proprio passato cinese».
«Civiltà»: la fase due
Il primo atteggiamento del PCC verso i valori culturali tradizionali cinesi è stato questo, ma oggi il Partito va nella direzione opposta.
Come osserva la Kaufman, negli ultimi decenni il PCC si è mosso all’inverso, abbracciando il passato della Cina e celebrando i «[…] valori “tradizionali” dell’antica civiltà cinese […] quale fonte di forza nazionale ed elemento essenziale del successo cinese di oggi». Questo atteggiamento sembra risalire alle Risoluzioni riguardanti un certo numero di importanti questioni inerenti il rafforzamento della costruzione della civiltà spirituale socialista, emesse dal Comitato centrale del PCC nel 1996. Il documento afferma, infatti, che sia i «valori tradizionali» cinesi sia la nuova «cultura rivoluzionaria» sono «[…] fonti importanti della “civiltà socialista” cinese». Da quel momento le cose sono quindi cambiate e la vecchia ostilità maoista verso la cultura tradizionale è svanita. Così Hu Jintao, Segretario generale del PCC dal 2002 al 2012 e presidente della Repubblica Popolare Cinese dal 2003 al 2013, ha rimodellato la retorica pubblica del Partito usando esplicitamente l’antica lingua confuciana e lo stesso Xi Jinping ha «[…] di fatto elevato la cultura “tradizionale” allo stesso rango, o quasi, della civiltà socialista».
Com’è possibile? «Il mutamento della condizione della Cina sul piano mondiale consente a Xi di rivalutare la civiltà cinese tradizionale non solo in relazione alla civiltà occidentale, ma anche in relazione alle aspirazioni socialiste cinesi». Come spiega la Kaufman, «Xi ha sostanzialmente eliminato le contraddizioni intrinseche esistenti tra l’ideologia del PCC e la cultura tradizionale cinese negando che vi siano mai state». Quindi, anche se «molti commentatori hanno notato che la riabilitazione della cultura tradizionale cinese operata da Xi sia selettiva, strettamente controllata e spesso in contrasto con la visione della storia che hanno gli altri», resta comunque il fatto che «[…] questi leader abbiano fatto del passato cinese un motivo di orgoglio nazionale e una rivendicazione di autonomia per il futuro “civilizzato” della Cina, la quale non è dunque tenuta a seguire la medesima strada intrapresa dalle civiltà occidentali».
Fedele a questa visione addomesticata del passato, quale futuro immagina allora il PCC? Oggi le autorità cinesi «[…] asseriscono che la Cina si trovi in una posizione unica per creare un nuovo tipo di futuro, nuovo non solo per la Cina, ma per tutta l’umanità». In altre parole, «[…] che la Cina debba guidare il mondo verso il futuro non è cosa in dubbio; se invece il popolo cinese sia pronto a farlo è cosa più dibattuta». Insomma, Hu Jintao e Xi Jinping pensano che «[…] la Cina non sia tenuta per forza a seguire il medesimo percorso lungo cui si sono incamminate i Paesi occidentali» per modernizzarsi e dichiarano «[…] che la cultura unica caratterizzante la Cina sia di valore pari alle altre civiltà e che questo crei una via nuova alla modernizzazione con speciali “caratteristiche cinesi”». Ancora di più: Hu Jintao e Xi Jinping affermano «[…] non solo che il Paese sia in grado di forgiare la propria strada per il futuro, ma che la Cina sia in grado di forgiare meglio il cammino verso il futuro dell’umanità intera». Come Xi ha proclamato nel discorso svolto nel 2017 a un seminario sulla sicurezza nazionale, che la Kaufman cita direttamente, «la Cina ha le qualità per essere un leader» in grado di «guidare la comunità internazionale nella costruzione di un nuovo ordine mondiale più giusto e sensato».
E “hanificazione” per tutti
Fin qui ho seguito la dottoressa Kaufman. La sua esaustiva spiegazione del duplice atteggiamento, maoista e post-maoista, tenuto dalla leadership comunista cinese verso la civiltà tradizionale del Paese è profondamente istruttiva e rivelatrice.
Per i non specialisti, però, occorre forse sottolineare ciò che per gli studiosi è in qualche modo ovvio. L’uso “selettivo” della cultura tradizionale cinese è, per definizione, spurio. Gli elementi spirituali e religiosi di cui è ricca la cultura tradizionale cinese vengono infatti esclusi dal revival, perpetuando l’idea che la Cina non sia mai stata “religiosa”, una vecchia teoria, questa, che gli studiosi moderni hanno confutato. La teoria nota agli studiosi come “eccezionalismo cinese”, in base al quale la Cina avrebbe ospitato l’unica civiltà senza religione nel mondo, è in gran parte un gioco di parole basato sul fatto che, prima di incontrare l’Occidente, la Cina non avesse una terminologia religiosa, né parole come “confessione”, “denominazione”, “religione” e forse persino “Dio”. Ma, come ha osservato lo studioso di Hong Kong David Palmer, «in Cina gli elementi base della religione sono gli stessi che altrove». La Cina ha sempre avuto una religione popolare estremamente ricca, in dialogo con sistemi elaborati come il taoismo e il buddhismo. Il mito di una Cina irreligiosa è invece stato creato dagli intellettuali laicisti cinesi del secolo XX, che consideravano le religioni “abramitiche” ‒ cristianesimo, ebraismo e islam ‒ come l’unico modello possibile di religione. «Ciò che è “eccezionale”», conclude Palmer, «non è la religione cinese, ma gli intellettualismi che sono riusciti a nascondere il fatto che, come in tutte le società umane, nella cultura cinese ci siano sempre stati gli stessi elementi base della religione presenti in tutto il mondo» (cfr. Is Chinese [Lack of] Religion Exceptional?, in Ryan G. Hornbeck, Justin L. Barrett, and Madeleine Kang (a cura di), Religious Cognition in China: “Homo Religiosus” and the Dragon, Springer, Cham [Svizzera], pp. 17-34). Quando dalla cultura cinese viene eliminata la religione, ciò che ne risulta è una cultura cinese falsa.
Oso però adesso muovere un passo oltre, usando l’erudizione della Kaufman per cercare di illustrare ciò che, in questa chiave, sembra essere il vero significato della recente decisione del regime di inviare 10 milioni di giovani “volontari” in zone povere abitate da culture “arretrate”. È infatti qui che entra in gioco il bisogno del PCC di “civilizzare” le aree rurali.
Per essere in grado di guidare il mondo grazie alla propria civiltà superiore (forse anche di imporla), la Cina ha anzitutto bisogno di portare tutta la propria popolazione a quella civiltà superiore. Questo implica uno sforzo da profondere a livello nazionale per eliminare tutti gli elementi “non superiori” delle culture tradizionali che non possano essere integrati nel socialismo della “Nuova Era”. È cio che chiamano “sinizzazione”.
Ma è un obiettivo sottile e violento: la grande civiltà antica di 5mila anni che i leader del PCC hanno arruolato a fianco della cultura rivoluzionaria onde forgiare la nuova superpotenza che guiderà il mondo è, ovviamente, la civiltà cinese; e questo, ovviamente, significa la cultura han. Di fatto, in questa prospettiva di dominio mondiale non c’è spazio per elementi spuri come le culture e le usanze non-han, ovvero non-cinesi. Le culture non-han sono i nuovi «Quattro vecchiumi» dell’era Xi Jinping, destinati a essere completamente eliminati dalla scena cinese e mondiale.
Lo storico cattolico gallese Christopher Dawson (1889-1970) è stato uno degli studiosi che nelle proprie opere ha meglio studiato l’origine del concetto di “cultura” dal vocabolo latino cultus, cioè “culto”, inteso come la pratica socializzata e comunitaria della religione da parte di una specifica comunità umana storica che, attraverso la fede, risponde alle grandi domande poste dall’esistenza, dando vita a una civiltà. Religione, cultura e civiltà non sono quindi solo strettamente interconnesse, ma sono soprattutto interdipendenti. È anche per questo motivo, quindi in parte seriamente, che le contro-culture e le anti-culture ideologiche come il comunismo tendono ad assimilare le minoranze etniche e le religioni in un unico gruppo che deve obbedire oppure soccombere.
Mao ha cercato di distruggere tutti gli elementi culturali tradizionali della civiltà cinese e tutte le religioni presenti in Cina che, ai suoi occhi, costituivano un pericolo, o quanto meno comportavano un ritardo, per la rivoluzione comunista atea. Dopo Mao, una tradizione purificata dal fuoco rivoluzionario e lavata nel sangue di innumerevoli vittime è stata usata come strumento di “religione civile” (o “civilizzata”) per “pacificare” (cioè per omogeneizzare) il Paese, convincere i cittadini cinesi della propria superiorità ed esigere da loro lealtà, promettendo il dominio del mondo. Le religioni vengono così trattate tutte allo stesso modo: o si omologano al Partito o bruciano in un inferno terrestre.
Wenming è il nome del nuovo ordine (mondiale) cinese, e significa che civiltà equivale a “sinizzazione” e che “sinizzazione” equivale ad “hanificazione”. Dieci milioni di coloni sono pronti a insegnarlo ai non-han in tutta la Cina.
Aggiornamento del 27 aprile 2019. John Dotson, direttore di China Brief, una pubblicazione della Jamestown Foundation (che è un istituto di ricerca e di analisi, fondato nel 1984 a Washington per sostenere la causa dei fuoriusciti sovietici, e che oggi informa su fatti ed eventi di attualità di importanza strategica per gli Stati Uniti d’America), ha pubblicato un’interessante analisi della decisione “colonizzatrice” della LGCC. Dotson la conclude dicendo: «Il nuovo programma annunciato dalla LGCC per mandare i giovani “in campagna” non è una riedizione della tragica storia della Rivoluzione Culturale cinese. L’annuncio dato dalla Lega in marzo indica infatti un programma che negli intenti è molto diverso rispetto a quelli del passato, un programma che cerca di organizzare meglio, e probabilmente di professionalizzare, alcune eredità dell’ideologia comunista. Se il documento della LGCC fornisce indicazioni, queste dicono che oggi il PCC considera la gioventù urbanizzata, istruita e informatizzata della Cina non solo più competente dal punto di vista tecnico, ma anche politicamente più affidabile dei giovani delle zone rurali meno sviluppate. Sembra che per formare l’avanguardia dell’ultima incarnazione dell’ideologia maoista vivente nella Repubblica Popolare Cinese la Lega stia puntando sul primo gruppo di giovani, non sul secondo».