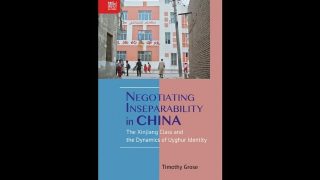Un convegno accademico alla George Washington University ‒ di ottimo livello scientifico e di grande partecipazione di pubblico ‒ illustra e conferma l’incubo che vive quotidianamente lo Xinjiang, là dove la religione è una “patologia” e un popolo intero viene sottoposto a “rettifica” poiché “sbagliato”
Marco Respinti
Washington – Mentre buona parte del pianeta continua a ignorare quanto accade ogni giorno in Cina, il mondo accademico (o se non altro una parte ‒ significativa ‒ di esso) scende in campo per chiedere alla comunità internazionale di salvare le minoranze etniche e le religioni perseguitate nel grande Paese asiatico. Una luce particolare sulla grave situazione che attanaglia la regione “autonoma” dello Xinjiang è infatti stata opportunamente accesa dal Simposio sull’incarcerazione di massa degli uiguri in Cina, organizzato e coordinato da Sean R. Roberts, antropologo culturale dell’Elliott School of International Affairs (ESIA) della George Washington University (GWA) di Washington. Parte del Central Asia Program dell’Institute for European, Russian, and Eurasian Studies della GWU, il convegno si è svolto martedì 27 novembre nella Lindner Family Commons dell’ESIA.
Il giorno prima, lunedì 26 novembre, Roberts e diversi suoi colleghi relatori il giorno seguente hanno del resto animato una significativa conferenza stampa al National Press Club, sempre di Washington, per denunciare ‒ senza timori per la carriera, come hanno tenuto a sottolineare ‒ la repressione in atto nello Xinjiang con il lancio di una dichiarazione firmata da 278 specialisti accademici di 26 Paesi e diverse discipline che chiede la cessazione immediata di ogni forma di coercizione e di vessazione attuata dal governo centrale e regionale della Cina contro gli uiguri. Ora, non accade tutti i giorni di vedere studiosi esperti e uomini tutti di un pezzo versare lacrime davanti alla stampa e alle telecamere, ma è quanto accaduto lunedì quando, aiutata da una interprete, ha preso la parola ‒ anche lei tra le lacrime ‒ Mihrigul Tursun, uigura di 29 anni, finita in un incubo che l’ha segnata per sempre nel fisico e nell’animo solo per avere un giorno deciso di recarsi in Egitto a studiare l’inglese ed essere così incappata in una vaga, infondata accusa di spionaggio. Hanno abusato di lei e dei suoi tre figli piccoli (uno dei quali è morto) in ogni maniera, costringendola a una carcerazione in condizioni letteralmente disumane, fatta di medicine ignote (somministrate anche ai figli) e di violenze di ogni genere. Ringraziando gli Stati Uniti per averle dato la possibilità di vivere in un Paese libero dove può liberamente essere uigura e liberamente vivere la propria fede musulmana, la giovane ha chiuso la propria testimonianza con due appelli. Il primo agli stessi Stati Uniti affinché non lascino mai soli gli uiguri perseguitati solo perché sono uiguri e credenti, il secondo a chiunque abbia la ventura di recarsi in Cina e là possa domandare per lei: «Dove sono mia madre e mio padre?».
DNA e Terzo Reich
Il convegno di martedì, articolato in tre sessioni, si è dimostrato un esempio di autentica eccellenza accademica. Relazioni dense e di alto livello che hanno documentato, anche nei dettagli raccolti attraverso esperienze dirette sul campo, quel che accade in una regione rimossa dall’immaginario collettivo.
Nella prima sessione, Le prove che i campi di rieducazione esistono, si sono alternati Timothy A. Grose, sinologo del Rose-Hulman Institute of Technology di Terre Hauste, in Indiana; Seiji Nishihara, economista dell’Università internazionale di Kagoshima, in Giappone; e Sophie Richardson, direttrice del dipartimento Cina di Human Rights Watch.
Grose si è concentrato sull’utilizzo, da parte del Partito Comunista Cinese (PCC), di un linguaggio medico atto a stigmatizzare come patologia il “terrorismo” e l’“estremismo religioso” attribuiti agli uiguri. Infatti, per il PCC essere uiguri e aspirare alla libertà equivale a essere terroristi (cioè alla definizione arbitraria che il Partito dà di “terrorismo”), laddove con “estremismo religioso” il governo di Pechino colpisce qualsiasi manifestazione identitaria della religiosità, dalla semplice preghiera personale al simbolismo sacro ostentato per esempio su indumenti o insegne pubbliche. Il solo essere uiguri (una etnia, cioè, che è quasi tutt’uno con una fede) costituisce insomma non solo un reato, ma configura persino una malattia, giacché appunto “terrorismo” ed “estremismo religioso” (nell’accezione comunista), che sono presentati come rovesci della medesima medaglia, vengono considerati malattie. Gli uiguri vanno così curati, e questo è esattamente ciò che si propone di fare la “missione civilizzatrice” del PCC. In questa cura sono del resto comprese la limitazione del contagio e la cauterizzazione delle ferite aperte: vale a dire la persecuzione aperta, gestita però propagandisticamente come misura di igiene nazionale.
Nishihara ha poi osato l’inosabile, affondando il coltello nella piaga. Perché mai il PCC, si è chiesto più o meno retoricamente, si sforza di trovare nomi alternativi ai propri campi di “rieducazione” ridicolmente indicati come centri di “aggiornamento professionale”? Perché cerca in tutti i modi di evitare che vengano chiamati per quello che sono, cioè campi di concentramento, e questo per il semplice motivo che tale dizione ricorda il nazionalsocialismo tedesco e lo sterminio sistematico di milioni di innocenti. Eppure la realtà dei campi cinesi è, per molti aspetti, identica a quella dei campi istituti dal Terzo Reich: lo stesso disprezzo della persona e la medesima arbitrarietà. Un punto li rende però davvero simili. Non è vero che gli uiguri, dice Nishihara, siano perseguitati perché separatisti. Magari alcuni di loro lo sono anche, ma il motivo per cui il PCC li colpisce è proprio solo perché sono uiguri, cioè portatori di una identità culturale e religiosa “diversa”, e dunque intollerabile per il regime. Lo mostrano bene molti casi, ma in specifico lo dimostra rotondamente il caso di tre intellettuali, Satar Sawut (ex direttore del Provveditorato agli studi dello Xinjiang), Yalqun Rozi (scrittore e critico letterario) e Tashpolatt Teyip (già presidente dell’Università dello Xinjiang), scomparsi l’anno scorso perché critici degli ultimi sviluppi repressivi ancorché ligi servitori del PCC e dunque per nulla separatisti.
La Richardson ha quindi portato l’attenzione su un’altra questione nodale. La struttura di controllo che il PCC riserva per gli esuli all’estero, un problema che i rifugiati patiscono in maniera cogente e che vivono con timore enorme. Il regime di Pechino impiega del resto tecnologia sofisticata, sottoponendo per esempio chi richiede il passaporto al prelievo di DNA onde mappare capillarmente il “dissenso”. Del resto, si chiede la Richardson, a chi si possono rivolgere i profughi quando il PCC intima loro, in Paesi stranieri, di rimpatriare immediatamente, pena guai seri per loro e per i familiari? Come possono essi rispondere?
Il “paternalismo” e la diaspora
La seconda sessione, L’impatto dei campi sulle comunità uigure, ha visto intervenire Joanne Smith Finley, sinologa dell’Università di Newcastle, in Gran Bretagna; Darren Byler, antropologo dell’Università di Washington; Elise Anderson, etnomusicologa all’Università dell’Indiana a Bloomington; e Dilnur Reyhan, studiosa della diaspora uigura all’Institut national des langues et civilisations orientales di Parigi.
La Finley ha offerto impressioni di prima mano sul completo mutamento della società dello Xinjiang a seguito della recente recrudescenza nella repressione degli abitanti della regione, una regione stretta nella paura e angosciata dall’incertezza. Ricollegandosi all’intervento di Grose, la studiosa ha sottolineato l’approccio psichiatrico al problema della religione privilegiato dal PCC, il quale tratta i fedeli come alienati da rendere inoffensivi e da rettificare. Il suo discorso ha pure sfiorato il tabù che nessuno osa citare, ma di cui vi è invece grande evidenza: il genocidio etnico e culturale che sta falcidiando lo Xinjiang. Un concetto cruciale introdotto dalla Finley è quello di “paura della moschea”: il “sacro” terrore, cioè, che il PCC nutre verso tutto quanto richiami anche lontanamente la fede degli uiguri, che va estirpata con una secolarizzazione forzata e imposta di costumi, usanze e tradizioni che vengono laicizzate e sinizzate.
Sulla medesima lunghezza d’onda, Byler ha documentato il “paternalismo rieducativo” implementato dal regime nella regione uigura. Human Rights Watch stima che circa il 10% degli uiguri siano oggi internati nei campi di concentramento “rieducativi”. Milioni di persone sono quindi sottoposte a “modificazione” e un milione di funzionari governativi, come Bitter Winter ha documentato, sono impiegati nel monitoraggio dei musulmani etnici. Lo Stato funziona insomma da “Grande fratello” orwelliano che, con la scusa della sicurezza nazionale, soffoca la società e le credenze religiose attraverso un controllo sempre più stretto ed efficace.
La Anderson ha poi proseguito su toni non dissimili, illustrando come questo “paternalismo” si esplichi in modo esemplare nell’imposizione di un’arte – la musica – che gioca su registri apparentemente tradizionali, ma che invece serve, mediante un bombardamento continuo di cui è fatta oggetto tutta la società, per svuotare di contenuto la musica identitaria e rettificarla secondo le parole d’ordine ideologiche del Partito, che in questo modo penetrano surrettiziamente nella società. Un suo richiamo è particolarmente significativo. La lingua uigura, segno dell’identità di un popolo intero, andrà scomparendo. La nuova generazione, infatti, dice la specialista, manca pressoché totalmente di poeti, custodi ubiqui della lingua, e questo finirà per fare il gioco del PCC.
Importante l’intervento della Reyhan, che ha illustrato la divisione profonda esistente tra i gruppi della diaspora uigura in Occidente e capace spesso di vanificarne le iniziative. La faglia corre principalmente sul fronte dell’indipendenza, dividendo chi la invoca apertamente da chi invece, interessato principalmente ad altro, parla solo, talora genericamente, di autonomia, ma soprattutto di diritti umani e libertà religiosa. Ovviamente la situazione è strumentalizzata dal PCC, che pure definisce tutti, appositamente omettendo le distinzioni, come separatisti, dunque come terroristi.
Biopolitica e Bitter Winter
La terza sessione, La contestualizzazione dei campi di rieducazione, ha visto avvicendarsi al microfono James A. Millward, storico della Georgetown University di Washington; Sandrine E. Catris, storica dell’Augusta University, in Georgia; il professor Roberts della GWA; e Michael Clarke, ricercatore all’Australian National University di Canberra, esperto di storia e società dello Xinjiang.
Millword ha scelto un argomento originale. Gli imperi, entità sovranazionali per definizione, ha detto, hanno sempre saputo affrontare efficacemente il pluralismo culturale, linguistico e religioso. Certo, gli imperi storici sono stati tutti diversi l’uno dall’altro, ma hanno comunque favorito una composizione sociale sicuramente non democratica nel senso moderno e però oggettivamente funzionale. Gli Stati-nazione, che per definizione sono la negazione degli imperi, non hanno invece mai saputo affrontare adeguatamente il problema: affetti da nazionalismo endemico, l’hanno piuttosto sempre esacerbato. Difesa da posizioni non certo nostalgiche, la questione, ha affermato Millword, riaffiora costantemente. La Cina di oggi ha di fatto ereditato un impero, ma lo ha trasformato in uno Stato-nazione enorme in cui il nazionalismo, sotto forma di sinizzazione, ha trasformato il socialismo di partenza in un guaio nazionalista ancora maggiore.
Decisivo il parallelo tra il regime di Xi Jinping e la Rivoluzione Culturale (1966-1976) promossa dal presidente Mao Zedong (1893-1976) che è stato illustrato efficacemente dalla Catris mettendo in evidenza i paralleli esistenti tra le due fasi storiche in tema di educazione forzata, assimilazione delle minoranze, repressione dura alternata a tentativi di addomesticamento delle religioni, incarcerazioni di massa, impiego del lavoro forzato e richiesta a tutti di osservare inderogabilmente la fedeltà rigida alla linea del Partito quale che essa sia. Vi sono poche differenze tra allora e oggi, ma forse, visto che pochissimi ne parlano, oggi è peggio di allora.
Roberts ha quindi illustrato puntualmente l’accusa di terrorismo mossa sistematicamente dal PCC agli uiguri. Richiamando tutti alla necessità di approfondire con oculatezza la nozione stessa di “terrorismo”, che va cioè tarata minuziosamente a seconda dei casi specifici e invitando così a distinguere con rigore tra gruppi, propaganda politica e realtà storica, l’antropologo ha utilizzato la categoria di “biopolitica” elaborata dal filosofo francese Michel Foucault (1926-1984) per ricordare l’equazione tanto speciosa quanto pericolosa operata dal PCC. Per il regime di Pechino essere terroristi equivale a essere malati; ma i malati sono anzitutto le persone religiose; dunque essere affetti dal morbo dell’“estremismo religioso” equivale a essere terroristi. È un nastro di Moebius funzionale al loop dell’“apostolato ideologico”, che spesso gli occidentali prendono acriticamente per vero (rendendosi complici dei crimini del PCC) e che a Xi Jinping serve per reprimere brutalmente milioni di persone in realtà non violente.
Per ultimo Clarke ha portato l’attenzione sulle cause della nuova, recente ventata repressiva, domandandosi «Perché adesso?». La sua risposta è un insieme di concause che hanno a che fare con la geopolitica, la sicurezza e l’economia. Parandosi fisicamente davanti alla marcia della Cina verso occidente, lo Xinjiang è vissuto da Pechino come un tassello irrinunciabile (al pari del Tibet) della salute pubblica e della sicurezza nazionale cinesi oltre che come nuovo mercato per l’iperproduttività del Paese. Solo che, dice il PCC, lo Xinjiang va svecchiato dalle usanze e dalla fede che ne frenano la modernizzazione utile a farne un nuovo, enorme teatro del consumo. E poi, dato che la Cina sta in qualche modo cercando di esportare il proprio “pacchetto sicurezza” repressiva, il grande esperimento di ingegneria sociale attuato nello Xinjiang costituisce una vetrina strategica.
Concluso da una vivace tavola rotonda animata dalle domande dal pubblico ‒ nel quale sedeva anche Rebyia Kadeer, leader morale storica del modo uiguro ‒ il convegno ha dimostrato con chiarezza una realtà inoppugnabile. La verità sulla repressione comunista cinese è ben nota, solidamente documentata e perfettamente compresa, anche nei dettagli, dagli studiosi. Come sempre, invece, la società civile, la cultura di massa e persino la politica segnano il passo. Bitter Winter è nato ed esiste per contribuire a colmare questo gap fra specialisti e opinione pubblica, cercando costantemente il modo per raccordare questi due mondi per molti aspetti lontani. Il fatto che tutti gli studiosi relatori al convegno di Washington e pure amplissima parte del pubblico abbiano mostrato di conoscere conoscere conosca, apprezzare e anche utilizzare fattualmente Bitter Winter, salutandone con favore enorme il fatto che esso pubblichi molto spesso notizie altrove irreperibili, e sempre in modo documentato e certificato, è allora un fattore di grande importanza. Non per campanilismo, ma come conferma del fatto che quanto si sta qui facendo quotidianamente, al prezzo di rischi enormi corsi da molti dei nostri corrispondenti e collaboratori, è quanto è necessario fare.