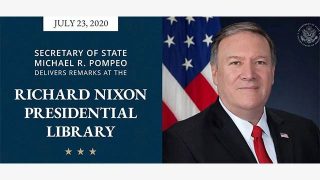Più di un milione di uiguri soffrono in prigionia nei campi per la trasformazione attraverso il lavoro, ma milioni di loro vivono ancora in quella sorta di terra di nessuno che è l’insicurezza più assoluta, dove una parola incauta o un capriccio burocratico potrebbero farli finire dietro le sbarre
Ruth Ingram
Chi gode ancora della libertà può anche non essere in galera, ma l’inflessibile pugno di ferro di posti di blocco, metal detector, controlli dei documenti e intercettazioni telefoniche continua senza tregua, e il filo spinato o le barriere di sicurezza alla navigazione online aumentano quotidianamente. In questo gioco orwelliano del gatto con il topo, non esistono né regole né certezze, e pochi escono vincitori.
Gli studenti, in particolare, camminano sul filo del rasoio. All’apparenza sembrano più al sicuro rispetto agli altri per quanto concerne retate casuali e incarcerazioni, ma sanno che l’attenzione per nulla desiderabile delle autorità è sempre a un passo da loro. La sensazione di tensione, in cui vivono costantemente, è palpabile.
«Dall’istante in cui ci alziamo fino a quando non torniamo a posare la testa sul cuscino, siamo sotto controllo», racconta Mehmud, uno studente musulmano uiguro al secondo anno dell’Università dello Xinjiang, a Urumqi. «È impossibile sfuggire». «Ci è stato detto che la nostra religione è un virus che necessita di essere curato e che l’unico modo per farlo è rinchiuderci e “trattarci”».
L’ingresso al campus attraverso un tornello di sicurezza che pare quello di un aeroporto, con tanto di metal detector, strumenti a raggi x, software di identificazione dei documenti e scanner facciale, è riservato agli studenti e allo staff. I visitatori devono essere registrati e accolti dai propri ospiti, senza alcuna eccezione. Anche la libertà delle squadre degli addetti alla sicurezza, oberati di lavoro, è in gioco, qualora lascino penetrare all’interno un potenziale “terrorista”. «Lavoriamo 12 ore al giorno sette giorni su sette, ma i nostri stipendi vengono bloccati a 400 yuan (circa 60 dollari statunitensi) se solo ci prendiamo un giorno libero», lamenta Nafisa, madre di tre figli, vestita con il giubbotto mimetico antiproiettile. Per questo periodo di “emergenza”, come lo chiama lei, ha mandato i figli a vivere da un parente. «Ci viene detto ogni giorno che ci troviamo in stato di massima allerta», racconta. «Questa settimana ci è stato raccomandato di essere particolarmente vigili. Non abbiamo idea di quale sia l’emergenza, ma ogni settimana pare ci sia sempre un motivo nuovo per stare in guardia». Nafisa non può rischiare di lasciar passare la persona sbagliata. «Tanti amici se ne sono andati. Io ho una famiglia. Cosa accadrebbe ai miei bambini se io fossi presa dalle autorità?».
Non solo ogni centimetro quadrato del campus universitario è monitorato attraverso dispositivi di identificazione e scanner facciali, ma a tutti gli studenti è stato detto di sorvegliare i compagni che eventualmente deviassero dalla linea del Partito. A questo mirano le riunioni politiche obbligatorie del mercoledì pomeriggio, durante le quali i concetti di sicurezza e di fedeltà al governo sono inculcati a forza in chiunque ascolti. Fornire informazioni su un compagno non solo fa guadagnare punti dal punto di vista politico, ma può stroncare il dissenso sul nascere, impedendo agli amici di partire per la tangente e finire nelle pericolose pastoie del fondamentalismo, del separatismo o di altro peggio ancora. Si possono salvare vite, dice lo staff, che a propria volta è seriamente a rischio. Il “doppio gioco” con il Partito è infatti un crimine particolarmente grave.
Le inclinazioni religiose e i sentimenti anti-partito vengono stroncati con ferocia, ma lo sono anche altre forme di mormorio più sottili, come il malumore e le lamentele, l’essere semplicemente tristi o lo studiare la lingua di uno dei 26 Paesi “vietati”. Agli studenti è stato detto che persino appendere un planisfero sulla parete della propria stanza o progettare un futuro accademico all’estero sono comportamenti per cui tenersi vicendevolmente sott’occhio.
«Non possiamo stare tranquilli neppure un minuto», dice Turnisa, studente del terzo anno specializzando in Biologia. «Qualora ci sfuggisse qualcosa, e un nostro compagno di stanza fosse colto sul fatto, potremmo essere cacciati anche noi per non essere stati abbastanza attenti».
I campi di trasformazione attraverso il lavoro, la punizione attualmente preferita dal governo, è l’esito più temuto quando si compie un passo falso. Innumerevoli studenti uiguri hanno già visto i propri parenti condannati con processi extragiudiziali a più di 18 anni, e molti loro genitori o fratelli sono scomparsi del tutto. Già questo è sufficiente per macchiarne il libretto universitario e segnalarli come sorvegliati speciali. Vivono insomma quotidianamente in equilibrio sul filo del rasoio, senza sapere quando potrebbe venire il loro momento.
Per gli studenti, vivere e studiare in un’università in cui insegnanti e accademici uiguri sono scomparsi è particolarmente snervante. Qutluq Almas, un ex docente della Università dello Xinjang attualmente in esilio negli Stati Uniti d’America, ha raccontato al Servizio uiguro di Radio Free Asia che almeno 56 fra docenti e ricercatori uiguri dell’ateneo sono attualmente detenuti nei campi per la trasformazione attraverso il lavoro. Quando l’ex rettore, Tashpolatt Teyp, è improvvisamente sparito all’inizio di quest’anno, internato con l’accusa di tendenze “doppiogiochiste” semplicemente per aver prestato un’attenzione solo formale alle politiche del Partito, gli studenti hanno immediatamente avuto la terribile percezione che nessuno sia al sicuro.

La maggior parte degli accademici “scomparsi” ha qualche connessione con la cultura e con la lingua della nazione e del popolo uiguri, cosa che pone gli studenti a un bivio: proseguire con la specializzazione o lasciar perdere tutto? «Già studiamo la lingua e la letteratura uigure attraverso il cinese mandarino e utilizzando traduzioni», racconta Asmanjan, un ex studente del professore di letteratura Azat Sultan, ora scomparso. «Ma adesso pare sia un crimine anche conservare nelle nostre stanze i lavori del prof. Azat in originale o solo ammettere di averli avuti». Qualche mese fa, Asmanjan ha trascorso un’intera notte a stracciare tutti i libri uiguri che possedeva, nel caso in cui un controllo casuale delle stanze rivelasse la sua “slealtà” verso il Partito. Nuove liste di libri vietati vengono infatti pubblicate ogni settimana. E il ragazzo si è premurato persino di eliminare i singoli pezzi di carta stracciata, dal momento che le telecamere di sorveglianza tengono sotto controllo ogni discarica di rifiuti della città. «Cosa accadrebbe se mi vedessero sbarazzarmi delle pagine e se gli spazzini portassero quei frammenti alle autorità? E bruciarle sarebbe stato persino peggio», dice.
Gli studenti sono divisi. Alcuni temono di essere perquisiti da un momento all’altro, e aspettano solo che qualcuno bussi alla porta, mentre altri si sentono invece intoccabili. Gli studenti cinesi di etnia han sono tranquilli, dal momento che l’obiettivo principale delle purghe è la minoranza uigura; e, a meno che non nutrano un inusuale interesse per la cultura e per la lingua uigure, il governo ritiene di non avere nulla da temere da loro. Ogni settimana, le ispezioni delle stanze di tutti gli studenti, dei loro effetti personali, dei telefoni e dei computer assicurano che tutto sia strettamente sotto controllo, ma può sempre esserci qualche cosa di inaspettato che li coglie alla sprovvista.
Gli studenti uiguri possono essere segnalati per una gran varietà di “infrazioni”: per esempio essersi lamentati del clima in cui si vive oggi, non essersi tenuti al corrente delle ultime indicazioni impartite del presidente Xi Jinping, avere partecipato poco entusiasticamente al canto dell’inno nazionale cinese oppure non conoscerne le parole. Arrivare in ritardo per la cerimonia dell’alzabandiera del lunedì mattina, conservare nel dormitorio qualunque libro in lingua uigura, possedere qualsiasi materiale di tipo religioso sui telefoni, che del resto sono costantemente controllati: anche questi sono modi ovvi per infrangere le regole della “nuova era” di Xi, in cui la via da seguire è la “sinizzazione”.
Ogni influenza estera è sospetta, e il contatto con gli stranieri, che avvenga in Cina o all’estero, è sufficiente per far scattare un campanello d’allarme. Quest’anno il cinese mandarino, già noto come “Han Yu”, cioè lingua degli han, è stato ribattezzato “Guo Yu”, vale a dire “lingua nazionale”. Qualsiasi studente che venga sentito parlare la propria yu, cioè la lingua natia, nel campus, nei dormitori e in modo particolare nelle classi, viene severamente rimproverato e invitato a usare la lingua nazionale. Le avvisaglie di questo monolinguismo incombente si vedono ovunque nel college, dove i testi uiguri, che in precedenza erano bilingue, sono stati brutalmente vietati, lasciando esclusivamente quelli in mandarino. «Ci è persino stato vietato di usare la nostra lingua madre tra noi», racconta Gulnur, una studentessa del primo anno della facoltà di Storia, a cui il mandarino risulta difficile. Nata in uno sperduto villaggio del sud dello Xinjiang, è cresciuta parlando esclusivamente uiguro, e ora sta lottando duramente con l’enorme difficoltà del vocabolario e dei caratteri speciali della scrittura, che però sono fondamentali per il suo corso di studi.
«Uno dei miei compagni era al telefono con la sua fidanzata, in Uzbekistan. Due ore dopo aver riattaccato la cornetta, cinque poliziotti armati sono venuti a prelevarlo. Da allora nessuno l’ha più sentito», dice Polat, un dottorando che vive fuori dal campus.
La vita degli studenti scorre sul filo della paura e di una auto-censura continua. «Controlliamo noi stessi, le nostre amicizie, le nostre parole e persino i nostri pensieri», racconta Abdullah. La maggior parte dei suoi parenti è stata in un modo o in un altro privata della libertà, e sua madre si prende cura di dodici bambini, figli di vicini di casa e di parenti “scomparsi”, nel sud della regione. «Talvolta non mi capacito di come una persona possa reggere così tanto stress e sofferenza emotiva», continua. «Ma tutti noi stiamo vivendo in questo incubo, e nessuno sa quando finirà».
I raid notturni sono la norma, e non ti permettono di abbassare la guardia neppure la sera. «Abbiamo sempre un orecchio alle scale e uno al pianerottolo», aggiunge Polat. «Facciamo attenzione ai diversi modi di camminare e se per caso si sente il gracchiare dei walkie-talkie», dice. «Abbiamo imparato a distinguere il passo degli amici da quello dei nemici».
«Tiriamo un sospiro di sollievo quando bussano alla porta di qualcun altro, o del ragazzo della porta accanto. Ma c’è sempre un domani. Non si può mai sapere».