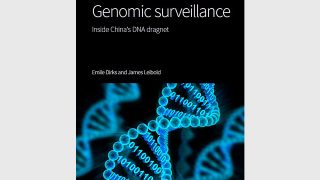Storia tragica della più grande incarcerazione di massa di un gruppo etnico dalla fine della Seconda guerra mondiale. E non è finita. Parla Zubayra Shamseden.
di Massimo Introvigne
Zubayra Shamseden proviene da una antica famiglia uigura profondamente religiosa. È coordinatrice del Dipartimento per la Cina dello Uyghur Human Rights Project (UHRP), un gruppo di documentazione e supporto che ha sede a Washington, e Fellow al Center for Women, Faith & Leadership (CWFL) dell’Institute for Global Engagement (IGE). Sin dalla fine degli anni 1980 promuove campagne per il rispetto dei diritti umani e per la libertà politica del popolo uiguro. Prima di entrare a far parte dell’UHRP ha lavorato come addetto stampa, ricercatrice e traduttrice all’ International Uyghur Human Rights and Democracy Foundation (IUHRDF) e ha collaborato per più di vent’anni con organizzazioni no-profit, accademiche e governative in Australia e negli Stati Uniti d’America.
Bitter Winter dà regolarmente conto della persecuzione dei musulmani uiguri. Abbiamo chiesto a Zubayra Shamseden di raccontare la propria storia e di descrivere la situazione in cui versa oggi il popolo uiguro in Cina. Come molti Uiguri, anche lei preferisce non usare il toponimo “Xinjiang” per indicare la provincia della Cina dove risiede la maggior parte del suo popolo. Infatti, per la maggior parte degli Uiguri questo termine, che è stato dato alla regione dalla dinastia cinese Qing e che significa “Nuova regione di frontiera“ o “Nuovo confine” (della Cina), contiene un’affermazione colonialista, motivo per cui gli Uiguri preferiscono utilizzare la dizione “Turkestan orientale”, un’espressione geografica coniata nel XIX secolo per indicare le due repubbliche del Turkestan orientale che per breve periodo sono state indipendenti dalla Cina: la prima, una repubblica islamica, negli anni 1933-1934 e la seconda, sostenuta dall’Unione Sovietica, nel periodo 1944-1949. A propria volta, i cinesi contestano sia l’uso dell’espressione “Turkestan orientale” sia la legittimità della prima e della seconda repubblica del Turkestan orientale. Per risolvere il problema, lo studioso statunitense Rian Thum ha suggerito di utilizzare il vecchio nome “Altishahr” (Sei città), ma è una proposta che non tutti accettano.
Lei è stata a lungo un’attivista in difesa della cultura e dei diritti degli Uiguri. Può raccontarci la sua storia personale?
Sono nata e cresciuta in una famiglia uigura religiosa e colta. I valori della mia famiglia, che in effetti sono quelli di tutta la società uigura, sono la lotta per una vita pacifica e felice. La nostra tradizione culturale e religiosa insegna che pace e felicità provengono da una famiglia e da una società giuste, eque e oneste. E, cosa più importante, tutto questo inizia dall’alto. Un governo è tenuto a governare sulla base di questi princìpi morali e proteggere tutti i cittadini.
Sono stata educata sino alla scuola superiore nella mia terra natia, il Turkestan orientale (lo Xinjiang) e mi sono laureata in un’università nella Cina interna. In realtà, ho conseguito un diploma in Cinese nell’Università industriale dello Xinjiang, e una laurea in Scienze bibliotecarie e dell’informazione nell’Università della Cina orientale (华东 师范大学) di Shanghai. Dopo gli studi universitari, sono tornata nella città in cui sono nata e ho lavorato per l’Accademia delle scienze. All’inizio, siccome avevo frequentato l’università nella Cina continentale con altri studenti cinesi, ho ricevuto un trattamento simile agli altri. L’Accademia mi ha coinvolta in alcuni progetti, in particolare in una rilevazione condotta nella parte sud del Turkestan orientale nel 1990 e ho anche insegnato informatica agli studenti uiguri di un college della zona. Poi ho studiato un anno Lingua e letteratura russa nell’Università statale del Kazakistan orientale, rientrando nel mio Paese nel 1992.
Le mie esperienze di studio e di lavoro mi hanno dato la possibilità di conoscere la situazione educativa, culturale e sociale degli Uiguri. Ci è stato insegnato e siamo tenuti a sostenere che, se la società uigura era all’epoca poco sviluppata nei campi dell’istruzione, dell’economia, della cultura o in altre aree, questo era dovuto alla “pigrizia” degli Uiguri che non parlavano la lingua cinese e che non erano disposti a integrarsi nella società cinese. Tuttavia, le esperienze della mia infanzia e l’essere stata testimone, da adulta, del trattamento riservato alle “minoranze” in quel territorio che la Cina chiama “Xinjiang” mi hanno insegnato la verità dell’esatto contrario. Era cioè il governo cinese a isolare sistematicamente gli Uiguri, chiedendo loro di fare “autocritica” se non parlavano bene il cinese e diffondendo l’idea che dovessero sempre sentirsi inferiori. Allo stesso tempo il governo imponeva ovviamente la censura più rigorosa e manteneva stretto il controllo sui piani economico e politico.
Ho iniziato a farmi domande quando lavoravo nell’Accademia delle scienze. Ho chiesto all’amministrazione come mai la sede di quella istituzione nello Xinjiang non funzionasse allo stesso modo della sua sede di Shanghai. In quel periodo a Shanghai non si tenevano affatto incontri politici, quindi perché noi, nello Xinjiang, dovevamo invece partecipare a incontri settimanali di “educazione politica”? Forse che lo “Xinjiang” non faccia parte della Cina? Dopo quell’incidente, e anche a seguito del viaggio che ho compiuto in Paesi più aperti dell’Asia centrale, ho iniziato a guardare con occhi diversi l’attività dell’Accademia, così come quella del governo locale e delle forze di sicurezza. Vedevo che il mio futuro non poteva più essere nella mia città natale, anche se parlavo fluentemente il cinese, avevo un’ottima conoscenza della cultura cinese e mi ero laureata con il massimo dei voti. Alla fine ho lasciato il Paese nel 1993.
Ho quindi vissuto in Australia per i successivi 17 anni, dove ho conseguito un master in Studi internazionali nell’Università dell’Australia Meridionale, specializzandomi sui diritti umani degli Uiguri nella storia moderna. In quegli anni ho dedicato la maggior parte del tempo a lavorare per la nostra comunità, per contribuire alla cultura e all’educazione linguistica del nostro popolo, e per sensibilizzare il mondo esterno sulla situazione dei diritti umani degli Uiguri. Nel 2009 sono andata a lavorare negli Stati Uniti su invito di Rebiya Kadeer, la ben nota leader degli Uiguri. Ora faccio parte del Center for Women, Faith & Leadership dell’Institute for Global Engagement, un programma che favorisce la leadership delle donne credenti. Lavoro anche come coordinatrice del Dipartimento per la Cina del Progetto per i diritti umani degli Uiguri (UHRP). Il mio ruolo nell’UHRP è quello di raggiungere i cinesi, in Cina e nel resto del mondo, per aiutarli a comprendere le gravi violazioni dei diritti umani che gli Uiguri subiscono dalla prospettiva degli stessi Uiguri.
Quali sono le radici storiche di quella che per alcuni è la “questione uigura”?
Non esiste alcuna “questione uigura”. Vorrei sottolineare che si dovrebbe fare molta attenzione nella scelta dei termini che si utilizzano per descrivere quello di cui si sta parlando. Non esiste affatto quella che alcuni definiscono “questione uigura”, ma è molto problematico comprendere “che cosa chiedono gli Uiguri?” Gli Uiguri vorrebbero solo avere ciò che spetta loro in base alla legge internazionale sui diritti umani e alla Dichiarazione universale dei diritti umani, che è un documento fondativo del cuore dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Nessun uiguro vuole diventare la “questione” o il problema di qualcuno altro. Da un punto di vista storico e anche di attualità, gli Uiguri vogliono poter condurre una vita pacifica nella propria patria senza oppressione, inganni e devastazioni, ossia senza quella repressione di tipo colonialista dei loro diritti e delle loro libertà che hanno sofferto sin dal 1949.
Come si sta comportando la Cina nei confronti della popolazione uigura musulmana?
La Cina sta trattando l’intera popolazione uigura come un nemico dello Stato. Agli occhi del governo cinese essere Uiguri sta diventando un crimine. La detenzione in massa, senza giusto processo, di oltre un milione di Uiguri nei cosiddetti “campi di rieducazione” e la sorveglianza altamente tecnologica generalizzata che il governo ha organizzato nel Turkestan orientale stanno dicendo al mondo che la Cina è determinata a “riprogrammare” il popolo uiguro. Quasi due milioni di persone che non sono scomparse nei campi sono costrette a frequentare corsi giornalieri di “educazione politica”; in questi corsi, gli Uiguri sono costretti a rinnegare la propria fede e la propria identità, a cantare canzoni che elogiano il Partito Comunista e a gridare slogan di lode a Xi Jinping.
E gli altri musulmani cinesi?
Secondo alcuni rapporti ‒ come, per esempio, quello di Human Rights Watch del 9 settembre 2018 e quello recente dell’UHRP ‒, altri musulmani di ceppo turcofono, cioè kazaki, uzbeki, kirghisi e tartari, stanno patendo lo stesso trattamento che soffrono gli Uiguri nel Turkestan orientale. Per i musulmani Hui, che parlano il cinese come lingua madre e che sono diffusi in molte regioni della Cina, la situazione, secondo un eccellente rapporto di Freedom House, era abbastanza tranquilla fino a qualche anno fa.Tuttavia, resoconti più recenti indicano che adesso anche i musulmani Hui si trovano in difficoltà. In poche parole, il governo cinese considera la religione un “veleno”, in particolare religioni come l’islam, il cristianesimo e il buddhismo tibetano. La nuova campagna del PCC per la “sinizzazione” della religione sta aumentando la repressione delle fedi e causando grandi sofferenze ai credenti cinesi.
Con il presidente Xi Jinping la situazione è peggiorata? Perché?
Sì, è peggiorata. Il grandioso progetto di Xi chiamato “Una cintura, una strada” emblematizza il suo desiderio di imporsi come un leader onnipotente, come un imperatore cinese che nella visione del mondo delle dinastie del passato, stava al centro del mondo intero. La sua paranoia e il suo bisogno di controllare ogni cosa si riflettono su tutti i funzionari che sentono di dover “colpire duramente” qualsiasi dissenso oppure verranno loro stessi accusati di infedeltà al Partito Comunista. Gli Uiguri sono uno degli obiettivi principali di questa esigenza di controllo estremo, una esigenza che ha condotto alla più grande incarcerazione di massa di un gruppo etnico dalla fine della Seconda guerra mondiale.
Qual è la condizione in cui vivono gli Uiguri nei campi di “rieducazione”?
Stando ai rapporti e ai racconti di chi è passato da lì, le condizioni sono davvero orribili: prigioni sovraffollate, cibo scadente, torture, abusi, intense pressioni psicologiche quotidiane e una vasta gamma di punizioni. Gli Uiguri sono costretti a rinnegare più volte la fede criticando le proprie tradizioni e le proprie pratiche religiose. Essendo musulmani, pare che vengano costretti a mangiare carne di maiale e a bere alcolici. In tutti i campi, e durante le lezioni di “indottrinamento politico”, sono costretti a cantare canzoni “rosse”, a lodare Xi e a dimostrare gratitudine verso il Partito Comunista Cinese. Si parla di decessi avvenuti in prigionia e in quei campi molti sono impazziti. Finora quasi nessuno è stato rilasciato vivo.
In che modo gli Uiguri all’estero stanno facendo sentire la propria voce?
Gli Uiguri all’estero si stanno battendo per difendere i propri diritti nonostante la paura e la disperazione per la sorte dei loro cari in Cina. In un forum svoltosi a Washington la settimana scorsa Rushan Abbas ha raccontato di aver perso i contatti con 14 nipoti, di età compresa tra i 3 e i 22 anni, oltre che con i loro genitori e nonni, da quando, nell’aprile 2017, sono stati aperti i nuovi campi; non sa dove si trovino e non può contattarli. In un video circolato recentemente sui social media, Turghunjan Tursun, un uiguro che vive in Turchia, ha parlato della propria moglie e dei propri figli piccoli che sono detenuti insieme a una decina di altri parenti.
I difensori dei diritti umani degli Uiguri hanno incontrato funzionari della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato americano, oltre a ministri degli Esteri e a parlamentari di tutto il mondo. Le organizzazioni degli Uiguri, come il Congresso Mondiale Uiguro, hanno presentato documentazione dettagliata e rapporti paralleli sia agli organismi delle Nazioni Unite sia ai ministeri degli Esteri di tutto il mondo. Stiamo esortando tutti a riconsiderare l’atteggiamento del “business as usual” che mantengono nei confronti della Cina in un momento in cui essa detiene un milione o più di persone nei campi di internamento etnico. I vostri lettori possono fare lo stesso. Per favore, aiutateci a sensibilizzare l’opinione pubblica e chiedete ai vostri governi se l’atteggiamento del “business as usual” sia moralmente giusto in un momento in cui Pechino sta portando avanti una repressione etnica e religiosa estrema e pressoché incredibile.
Cosa può fare l’Occidente per gli Uiguri?
I funzionari cinesi responsabili di tutto questo, come Chen Quanguo, il segretario regionale del Partito, dovrebbero vedersi negati i visti d’ingresso in altri Paesi, e subire forti condanne e critiche da parte dei leader religiosi e di governo di tutto il mondo, ivi compresi i governi dei Paesi a maggioranza musulmana. Le università dovrebbero dire ai propri partner cinesi che non è possibile intavolare normali scambi accademici quando è in corso una sistematica campagna di repressione etnica e religiosa da parte del loro governo. I turisti dovrebbero chiedersi se si sentano a proprio agio a trascorrere le vacanze in un Paese impegnato in una enorme campagna di violazione dei diritti umani contro i propri cittadini musulmani turcofoni e contro altri fedeli.