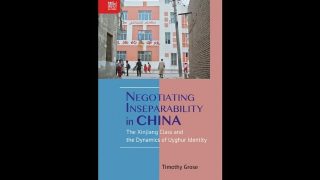Il manager di etnia han di una fabbrica di vestiti dello Xinjiang rivela dettagli inquietanti sugli abusi subiti dagli uiguri, che vengono mascherati da finti piani per migliorarne le condizioni
Di Chang Xin
Un uomo di etnia han della provincia settentrionale dello Shanxi che lavora come manager in una fabbrica di vestiti nel Sud della Regione autonoma uigura dello Xinjiang ha accettato di raccontare la propria esperienza professionale a Bitter Winter. Per proteggerne l’identità, l’uomo ha chiesto di essere chiamato «Wang Hao».
La fabbrica di Wang dà lavoro a più di mille uiguri. Per ordine del governo centrale tutti gli abitanti dello Xinjiang in età da lavoro devono essere assunti, comprese le donne con bambini piccoli. Usando vari metodi di impiego coatto, mascherati da politiche di riduzione della povertà, il PCC, inoltre, indottrina gli uiguri in nome dell’«eliminazione dell’estremismo religioso e del separatismo», nel tentativo di allinearne la visione del mondo a quella dell’ideologia del Partito. Adrian Zenz, uno dei principali studiosi dello Xinjiang, ritiene che, «in questo contesto, il lavoro venga esaltato come arma strategica per eliminare le ideologie “estremiste”».
Per svilupparne il senso della disciplina i lavoratori sono costretti a correre per un’ora ogni mattina prima di un turno di lavoro di 13 ore, che speso dura fino all’1 di notte. In proporzione alle ore lavorate, i salari mensili sono bassi: 500 renminbi (circa 70 dollari statunitensi) per i lavoratori comuni e solo un po’ più di 1.000 renminbi (circa 140 dollari) per i capi-squadra e capi-gruppo.

I lavoratori vivono presso la fabbrica e raramente ottengono il permesso di tornare a casa nei giorni di ferie. Qualche azienda impiega anche uiguri di 16 anni, i cui padri, nell’80% dei casi, sono detenuti in campi per la trasformazione attraverso l’educazione. In alcuni casi, entrambi i genitori sono internati. «Questi ragazzi sono infelici», dice Wang Hao. Sa che molti dei minorenni sono mandati al lavoro dalle scuole che firmano contratti con fabbriche come la sua.

«Gli uiguri detenuti che lavorano in fabbriche gestite dai campi per la trasformazione attraverso l’educazione sono lavoratori forzati, non ricevono alcuna paga», continua Wang Hao. «Ed è per questo che molte aziende li impiegano. Il governo chiama questi campi “corsi di formazione”, ma sono prigioni in cui i detenuti sono obbligati a lavorare la maggior parte del tempo».
L’estate scorsa il PCC dichiarava che la maggioranza degli internati nei campi fosse stata liberata e avesse trovato un “lavoro adeguato”. Successivamente, il governo ha iniziato a trasferire un gran numero di uiguri in altre zone della Cina per «risolvere i problemi dovuti al surplus di forza lavoro e per alleviare la povertà», come hanno affermato le autorità.
Wang Hao ritiene che il reclutamento forzato di uiguri non sia semplice come viene descritto e non abbia nulla a che vedere con la riduzione della povertà. «Lo Stato non vuole ridurre la povertà, ma trasformare l’ideologia degli uiguri», dice. «Il governo reprime la loro fede vietandone le abitudini, i costumi tradizionali, le feste religiose o la preghiera in moschea. Gli uiguri sono costretti a mangiare carne di maiale e possono avere un solo credo: il Partito Comunista Cinese».

Wang crede che l’educazione del PCC o le politiche del lavoro, adottate al fine della riduzione della povertà, abbiano peggiorato e non migliorato la qualità della vita degli uiguri.
«In passato, gli uiguri che lavoravano altrove, come nella provincia meridionale del Guangdong, potevano guadagnare un salario di 5mila-6mila renminbi (all’incirca da 700 a 840 dollari), dieci volte tanto quel che ora guadagnano lavorando nello Xinjiang», continua Wang. «Ma il governo ha obbligato la maggior parte degli uiguri a tornare nello Xinjiang, limitandone i movimenti. Possono lasciare la regione solo se hanno un permesso e solo se nessuno dei loro familiari, nelle ultime tre generazioni, è mai stato segnalato dalla polizia».
Wang conosce un uomo che lavorava nel settore dell’alta tecnologia nella provincia del Guangdong, dopo essersi laureato in un’università della Cina interna, ma il governo lo ha obbligato a rientrare nello Xinjiang. Ora lavora in una fabbrica di vestiti con un salario infimo, facendo una vita di stenti.
Wang sa anche del caso di un padre e dei suoi tre figli che lavoravano nella Cina interna, ma sono stati richiamati nello Xinjiang dove sono stati internati in un campo per la trasformazione attraverso l’educazione. Le mogli e i figli di questi uomini, una decina di persone, sono ora mantenuti dal quarto figlio che lavora nello Xinjiang e che a stento sbarca il lunario.
«Anche essendo uno han, sono d’accordo con chi dice che nello Xinjiang non siano rispettati i diritti umani», conclude Wang Hao.