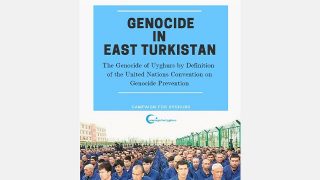Tornare a casa, di solito, è un momento di gioia, ma per gli uiguri che lavorano lontano ogni visita alla propria terra può concludersi in un campo di internamento
di Ye Ling

Per gli uiguri che vivono lontano da casa per lavoro tornare nello Xinjiang per fare visita alle famiglie e agli amici non è sempre una rimpatriata felice. Assomiglia piuttosto a un tranello: dal momento in cui entrano in casa dei familiari corrono il rischio di essere arrestati arbitrariamente e avviati alla “rieducazione”.
Baki, un musulmano di etnia uigura originario dello Xinjiang, stava lavorando come venditore ambulante nella provincia sudorientale del Fujian quando, qualche mese fa, ha ricevuto una telefonata di un funzionario governativo della propria città natale che gli ha ordinato di tornare a casa entro il 5 luglio per richiedere una carta di identità da migrante, come da «regolamento governativo unificato».
La cosa lo ha molto preoccupato; Baki temeva infatti che, una volta rientrato, sarebbe stato inviato in uno dei temuti campi per la trasformazione attraverso l’educazione. «Tornare a casa è semplice, ma tornare indietro non sarà altrettanto facile!», ha affermato l’uomo imballando la propria bancarella. «Il PCC esercita un controllo rigido su tutto lo Xinjiang. Non voglio proprio tornarci».
Baki ha affermato di conoscere un imam arrestato nel maggio 2017 e detenuto, ancora oggi, in un campo. Un altro imam è stato condannato a sedici anni di prigione. Baki ha un caro amico: i suoi suoceri e il fratello maggiore di sua moglie sono stati arrestati per aver accolto un ospite musulmano.
Dall’inizio del 2017 nello Xinjiang il regime comunista non ha smesso di costruire nuovi campi per la trasformazione attraverso l’educazione e ad ampliare quelli esistenti. Alcune delle stime effettuate afferma essere più di tre milioni fra uiguri, kazaki e appartenenti ad altre minoranze etniche il numero degli internati nei campi e prove sempre più numerose dimostrano come i detenuti siano sottoposti a varie tipologie di tortura e di abusi.
Baki ha raccontato che nella città in cui è nato tutti i maschi con meno di quarant’anni sono stati “rieducati” nei campi per la trasformazione attraverso l’educazione. «Credo nell’islam, leggo il Corano e parlo in lingua araba. Il governo vuole che ci liberiamo di tutto ciò. Se mi arrestano, temo che persino il Corano che porto nel cuore finirà sotto l’indottrinamento del Partito».
Presagendo forse di non potere mai più tornare nel Fujiang ha impacchettato tutti i propri beni. «Ci sono tante cose di cui non ho avuto il tempo di occuparmi», ha detto, guardando gli oggetti che ha potuto acquistare con il duro lavoro, quasi piangendo per la tristezza.
Non lontano da lui, illuminato dai lampioni, si vedeva distintamente un cartellone con l’immagine di Mao Zedong e i caratteri cinesi che recitano “fare piazza pulita delle bande criminali ed eliminare il male”. Baki ha camminato rapido verso il cartellone, ha stretto il pugno e l’ha colpito con forza. Con l’angolo della bocca ha imprecato «Che tu sia maledetta, Cina!», chiaramente desiderando sfogare a voce alta le emozioni soffocate ma non osando farlo.
La politica del PCC finalizzata a “trasformare” gli uiguri e gli arresti di persone a lui vicine hanno provocato a Baki uno stress terribile. Aveva paura di tornare a casa, temendo di finire in prigione. La sua famiglia ha pagato per suo conto all’amministrazione locale dello Xinjiang 10mila renminbi (circa 1.400 dollari statunitensi), sperando di poter rimandare il suo rientro obbligato. All’inizio di settembre, tuttavia, ha ricevuto un’altra telefonata da parte di un agente di pattuglia della sua città natale, che lo sollecitava a rientrare prima possibile, altrimenti avrebbero coinvolto la sua famiglia.
Baki non ha avuto altra scelta che lasciare il Fujian. Nessuno è in grado di dire se potrà tornarvi in sicurezza.
Tutti gli uiguri che lavorano nelle zone interne del Paese potrebbero essere obbligati a rientrare nella propria città natale in qualsiasi momento, senza alcuna ragione. Il timore di essere imprigionati al momento del ritorno a casa li segue come un’ombra.
Ran Na, una donna originaria dello Xinjiang che lavora in un’altra zona della Cina, ha raccontato a Bitter Winter che il marito è stato rinchiuso in un campo per la trasformazione attraverso l’educazione dopo che la polizia della regione l’ha richiamato indietro, nel giugno 2017.
«Mio marito si occupava di affari a Fuzhou, la capitale del Fujian. Ha sempre parlato un buon mandarino e sa parlare anche in fujianese [il dialetto Min del Fujian]. Quando le autorità hanno detto che volevano mandarlo a “studiare”, era solo una messinscena», ha detto Ran Na, aggiungendo che l’uomo sarà trattenuto per almeno due anni e mezzo.
La donna può vivere e lavorare al di fuori dello Xinjiang soltanto con la garanzia di un familiare. Gli agenti di polizia visitano la sua residenza attuale ogni settimana, per interrogarla; ogni volta le scattano anche delle fotografie. La donna ha paura e non osa pensare a ciò che accadrà in futuro.
«Per me è uno strazio. Posso soltanto pregare nel mio cuore», ha detto Ran Na. «Se non avessi potuto contare sulla preghiera, avrei avuto un crollo nervoso».
Per ragioni di sicurezza, tutti i nomi usati nell’articolo sono degli pseudonimi.